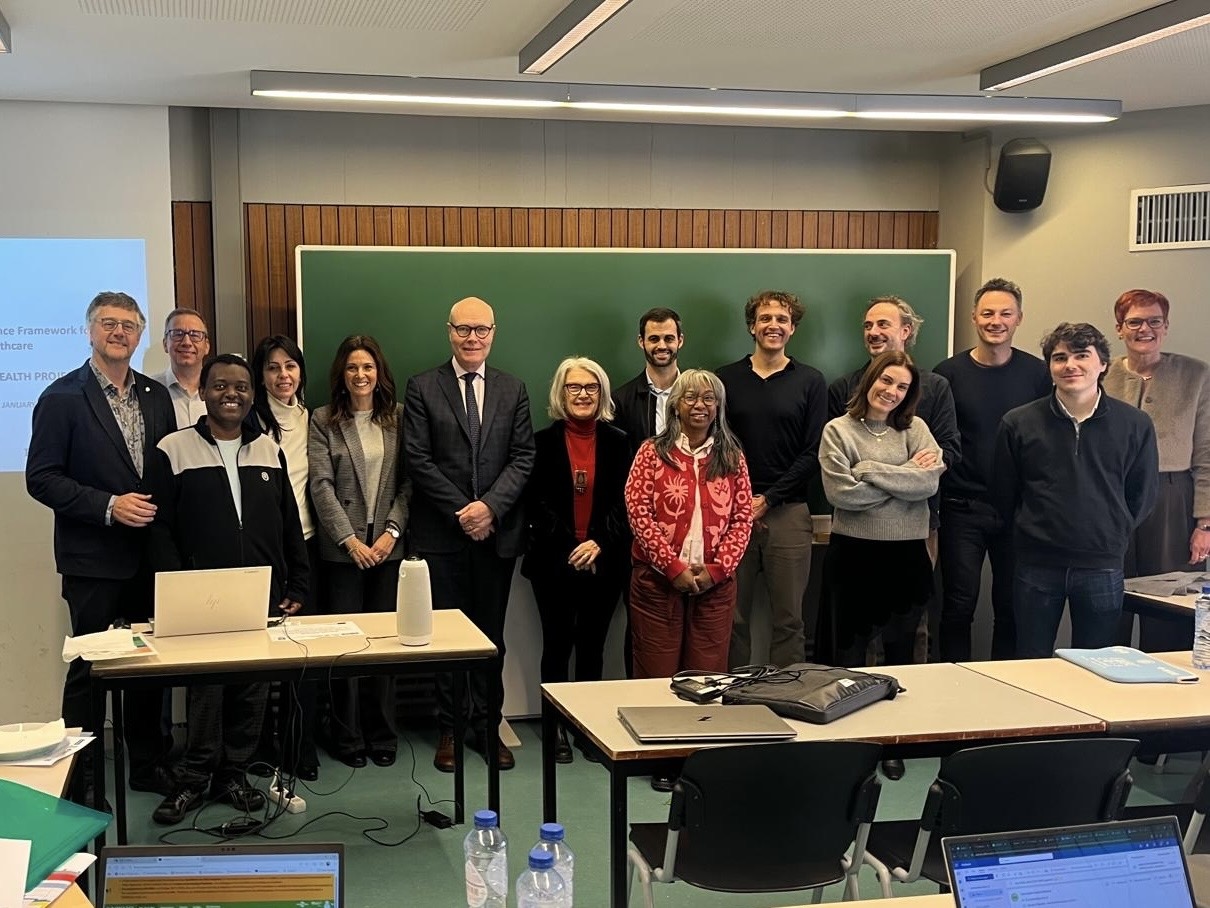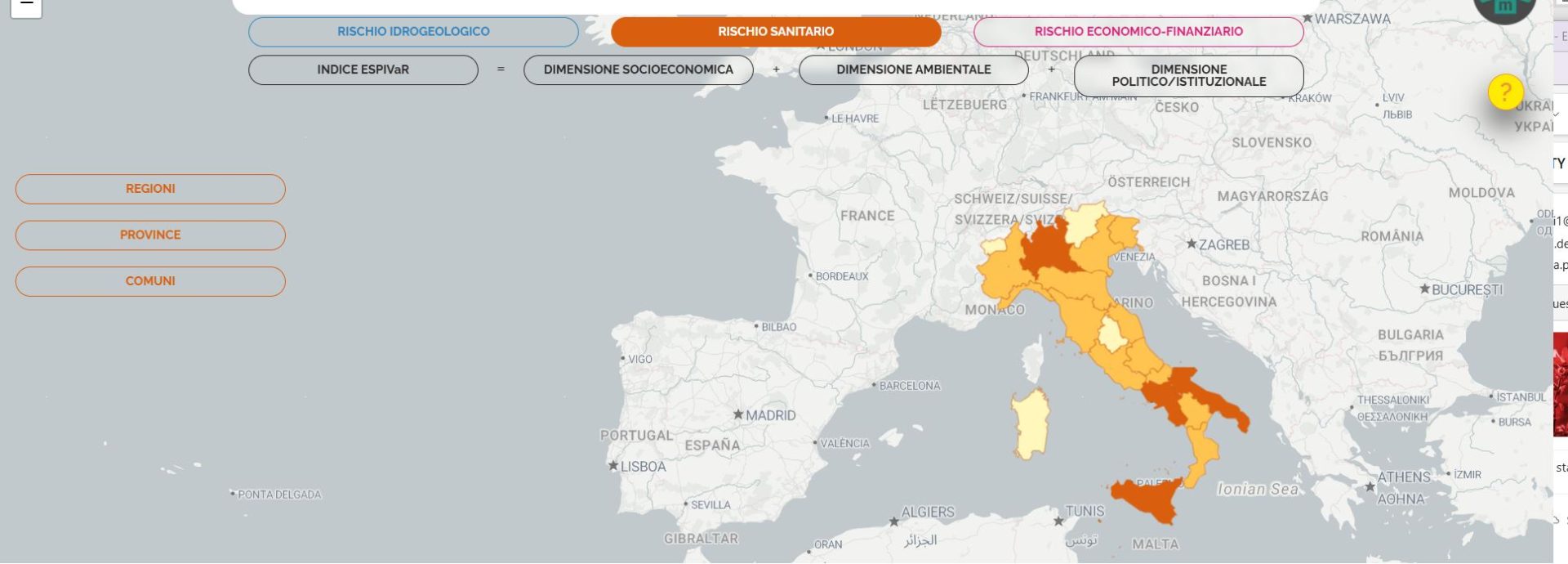Come tutelare la libertà e l’integrità della ricerca in un contesto globale, sempre più interconnesso, segnato da collaborazioni internazionali, nuove risorse tecnologiche ed equilibri geopolitici complessi? È a partire da questa domanda che l’Università di Macerata ha inaugurato il ciclo di incontri Dialoghi sulla ricerca, uno spazio di confronto critico, interdisciplinare e pubblico sulle questioni che attraversano oggi il mondo accademico.
Il primo appuntamento, tenutosi il 23 maggio 2025, è stato dedicato al tema Sicurezza, integrità e libertà della ricerca. Un titolo che restituisce la complessità e il carattere duplice dell’innovazione applicata alla ricerca: opportunità, ma anche rischio. Il panorama attuale della ricerca scientifica riflette infatti la realtà che viviamo quotidianamente al di fuori dalle aule universitarie: una rete capillare e potenzialmente infinita di risorse, conoscenze, incroci e scambi che rischia tuttavia di sgretolarsi e perdere autenticità se non adeguatamente monitorata e supportata da consapevolezza e spirito critico. Come emerso durante il convegno, in questo contesto è allora necessario bilanciare apertura e chiusura, libertà e sicurezza. Il che vuol dire proteggere conoscenze, dati e tecnologie sensibili da interferenze o appropriazioni indebite, senza per questo tradire i principi cardine della scienza aperta e della cooperazione internazionale.

Proteggere senza chiudere: un equilibrio necessario
Ingerenze malevole, trasferimenti indesiderati di conoscenze e tecnologie critiche, fughe di dati e violazioni dell’etica sono solo alcuni dei pericoli derivanti da un’apertura incontrollata. Riflettere sulla sicurezza della ricerca non significa tuttavia chiudere le frontiere del sapere, ma costruire un sistema in grado di aprirsi all’esterno con maggiore consapevolezza e responsabilità. Nel corso del dibattito, è emersa infatti la sfida a cui oggi ogni istituzione scientifica è chiamata a rispondere: trovare un equilibrio tra protezione dell’integrità dei dati e scienza aperta.
In questo scenario le Università hanno un ruolo centrale, non solo nel delineare regole e strumenti normativi, ma nel contribuire alla sensibilizzazione sul tema.
«I contributi che ogni singolo ateneo può dare in questo campo sono prima di tutto stimolare una riflessione critica e propositiva di come fare la miglior merging tra i due concetti di sicurezza e di apertura» – ha sottolineato Luciano Colombo, prorettore alla ricerca dell’Università di Cagliari e fisico teorico – e «un secondo impegno dovrebbe essere certamente quello della formazione, sia del proprio personale docente sia del proprio personale tecnico-amministrativo».
L’Università di Macerata al centro del dibattito europeo
L’Università di Macerata si è posta dunque come promotrice di un confronto che non ha solo valore accademico, ma sociale e politico. Aprire un dialogo sul tema della cultura della sicurezza nella ricerca significa infatti prendere parte a un movimento più ampio che coinvolge le istituzioni europee e nazionali. Proprio il 23 maggio 2024, esattamente un anno prima del convegno, il Consiglio dell’Unione Europea adottava una Raccomandazione sulla sicurezza della ricerca, invitando gli Stati membri a dotarsi di strumenti e politiche efficaci per garantire la sicurezza della ricerca scientifica.
Nel solco di questo invito si muove anche l’Italia, dove il Ministero dell’Università e della Ricerca ha avviato la definizione di un modello nazionale per la sicurezza della ricerca, coinvolgendo rappresentanti di CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane), COPER (Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca) e del mondo scientifico. Tra questi, anche Alessandro Mei, professore di Informatica alla Sapienza e membro del gruppo di lavoro ministeriale, intervenuto all’incontro di Macerata per delineare criteri e priorità del modello in discussione: dalla compilazione di schede di autovalutazione dei rischi da parte dei ricercatori a corsi di formazione, dalla tutela della proprietà intellettuale alla definizione di protocolli per la gestione dei pericoli legati a collaborazioni estere potenzialmente sensibili. Il modello italiano si allinea alle Raccomandazioni Europee senza perdere di vista, tuttavia, i due principi essenziali della ricerca, ricordati da Mei:
«La tutela della libertà del ricercatore e la comprensione del fatto che le collaborazioni internazionali sono un aspetto fondamentale per la ricerca scientifica, il progresso della scienza e in qualche modo dell’umanità».
A ribadire che bisogna essere in grado di proteggere gli ecosistemi scientifici senza rinunciare alla dimensione collaborativa e aperta della scienza, che è la sua linfa vitale.
Un’iniziativa che nasce da una vocazione pubblica
Anche Francesca Spigarelli, professoressa di Economia applicata all’Università di Macerata e già referente per la Virtual Academy del G7, sottolinea l’importanza di tradurre le raccomandazioni in strumenti operativi efficaci:
«Il Ministero, e l’Europa stessa, ci stanno dando delle indicazioni operative: per ora sono raccomandazioni, ma negli atenei dovranno arrivare delle indicazioni molto più pratiche su come il dialogo possa essere mantenuto, portato avanti e possa rappresentare effettivamente la stella polare per la ricerca che quotidianamente conduciamo».
Questo è vero più che mai per gli atenei a vocazione umanistica come quello di Macerata, che ha il compito di portare la conoscenza oltre le aule, condividerla, discuterla, metterla in relazione con la società e utilizzarla come strumento interpretativo della realtà. Lo ha sottolineato il Rettore John McCourt aprendo i lavori del convegno:
«L’università deve essere un luogo in cui la libertà della ricerca è garantita – e questo non possiamo più darlo per scontato».
Un ciclo che continua
Con questo primo incontro, l’Università di Macerata ha posto un primo tassello di un percorso che continuerà nei prossimi mesi. I Dialoghi sulla ricerca vogliono essere uno spazio aperto e continuo in cui la ricerca non solo produce conoscenza, ma riflette su se stessa, sui propri limiti e sulle proprie responsabilità.
Una consapevolezza che oggi appare sempre più necessaria. Perché la libertà della ricerca non è un dato acquisito, ma un bene da custodire, discutere criticamente e continuare a costruire insieme: in rete, ma in sicurezza.
COPERTINA – Foto di Sarah Noltner su Unsplash