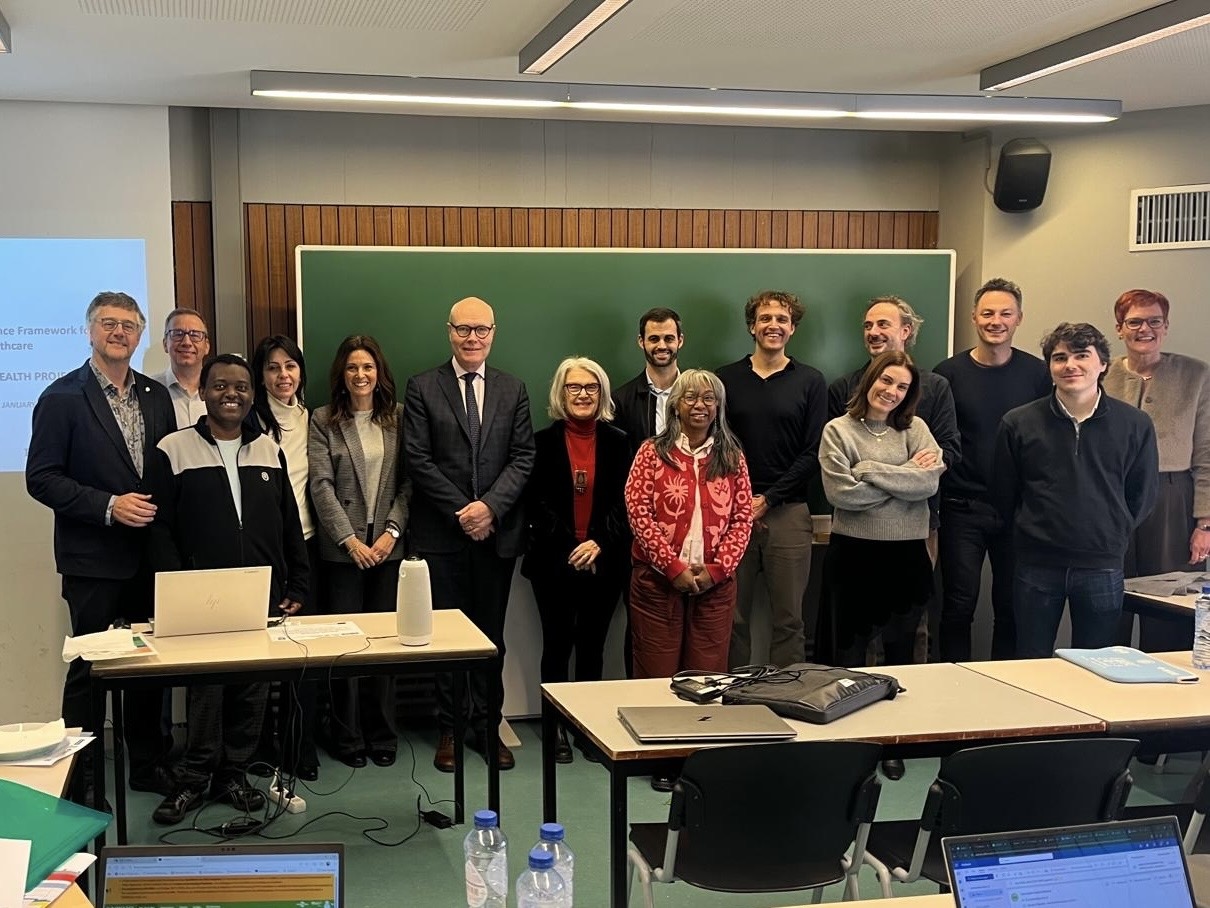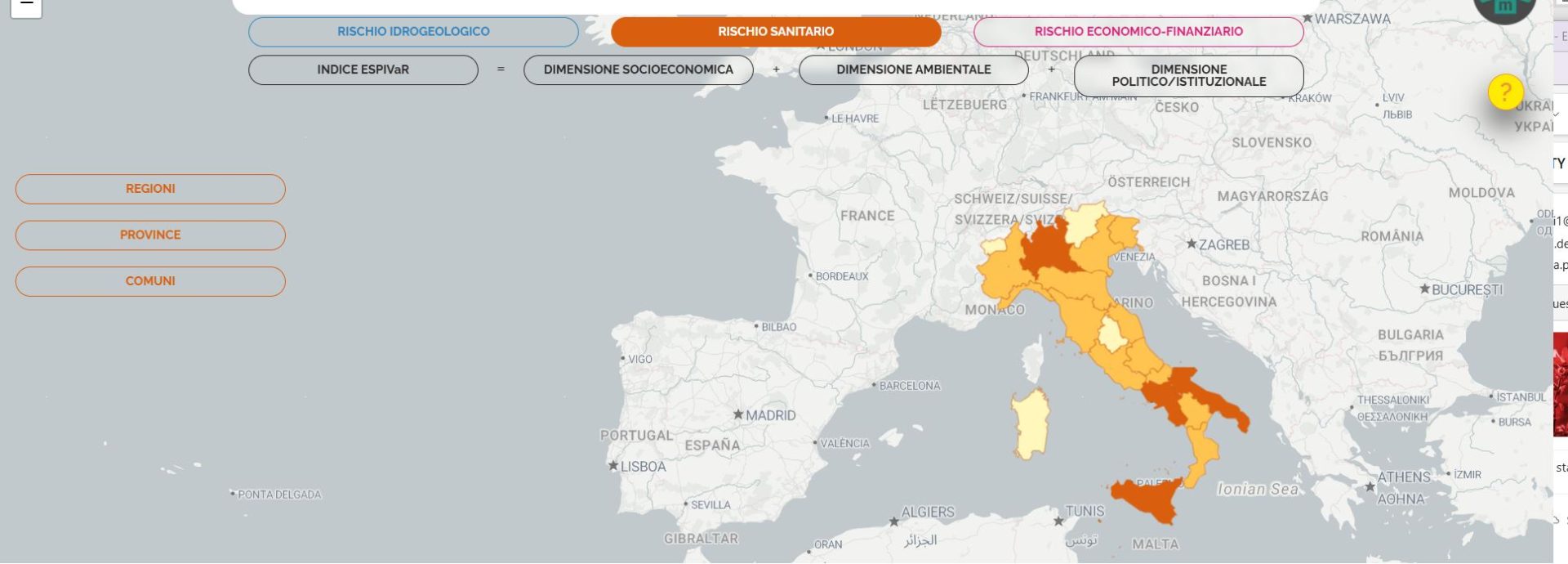Le sfide del giornalismo e della comunicazione in situazioni d’emergenza, tra cronaca locale e competenza ambientale: l’analisi del prof. Giacomo Buoncompagni
Foto: InsideEVs
Quando un disastro naturale colpisce un territorio, la comunicazione diventa un elemento cruciale per orientare la comunità e fornire informazioni vitali. Ma come si comporta il giornalismo di fronte a queste emergenze? Quali sono le competenze necessarie – e i problemi che si verificano – nel raccontare situazioni così delicate? Il prof. Giacomo Buoncompagni dell’Università di Macerata ha condotto due ricerche specifiche sul tema, analizzando da un lato il comportamento dei giornalisti locali durante l’alluvione in Emilia Romagna del 2023, dall’altro la competenza dei giornalisti specializzati nelle tematiche ambientali e climatiche. I risultati offrono uno spaccato interessante su come funziona l’informazione in situazioni di crisi.
La comunicazione nell’emergenza: caos emotivo e disinformazione
Cosa cambia nella comunicazione rispetto ad una situazione di normalità? «Cambia tutto, nel senso che in un primo tempo la comunicazione tra soggetti è fortemente emotiva, disordinata, e dipende da dinamiche strettamente personali che si verificano durante il disastro», spiega Buoncompagni. L’emergenza rappresenta infatti «un fenomeno di rottura di un equilibrio sociale, di una routine, di una normalità, ed ogni volta che si rompe la normalità chiaramente emergono alcuni rumori, alcune distorsioni nella comunicazione a livello sociale».
In questo contesto caotico, il giornalismo assume un ruolo fondamentale di orientamento e coordinamento, non solo a livello istituzionale ma anche come istituzione culturale. Tuttavia, anche nel mondo dell’informazione «si rompono degli equilibri, soprattutto nelle realtà giornalistiche locali, in prima linea durante situazioni del genere». Un aspetto spesso trascurato è l’impatto psicologico sui giornalisti che coprono le emergenze. «Il disastro è un trauma, soprattutto per chi magari, mentre lavora, perde un familiare, e questo è capitato». Queste “rotture biografiche” rendono difficile mantenere una lucidità e un’etica professionale impeccabile, ma «questo purtroppo non è un aspetto percepito dall’opinione pubblica».
Il giornalismo locale: forza e debolezza nell’emergenza
Il caso dell’alluvione in Emilia Romagna ha dimostrato l’importanza strategica del giornalismo locale. «Il giornalismo locale è stato in grado di dialogare fortemente con quello nazionale, ed è questo che ha “tenuto in piedi” l’informazione durante il disastro, dal momento che testate ed emittenti nazionali – come di solito accade in tali circostanze – hanno avuto difficoltà infrastrutturali nel raggiungere i luoghi colpiti e raccontarne le concitate ore», racconta il professore.
Tuttavia, la vicinanza territoriale del giornalista locale può rappresentare anche una debolezza: «Il giornalista locale conosce la comunità, conosce le vie della città, conosce le situazioni politiche», e ciò comporta anche un’intimità nelle relazioni, che può portare a bias, idee tendenziose ed errori informativi che minano la professionalità delle notizie, e quindi l’affidabilità della fonte.
I giornalisti specializzati: competenza vs percezione
Parallelamente ai giornalisti locali in situazioni di emergenza, esiste «una realtà italiana, anche se molto piccola, di giornalisti specializzati nei cambiamenti climatici, nei mutamenti ambientali». Questi professionisti, spesso laureati in discipline scientifiche o ambientali, nella gran parte dei casi sono anche impegnati da un punto di vista sociale su questi temi.
La specializzazione porta vantaggi evidenti: «Possiedono un focus ben specifico ancora prima dell’inizio dell’emergenza, e permettono di fornire un quadro più completo già nell’immediato, utilizzando termini tecnici e andando direttamente sul punto».
Tuttavia questa competenza – che ovviamente viene spesa, più che in situazioni di emergenza, nella quotidiana pratica giornalistica e di analisi dei problemi odierni – può diventare un’arma a doppio taglio.
«Questa competenza specifica rischia di essere letta come “di parte”, come una sorta di militanza ambientale. La troppa specializzazione rischia di creare una sorta di bolla sia per se stessi che da parte dell’opinione pubblica, dove paradossalmente la competenza che dovrebbe essere un elemento di credibilità diventa un’etichetta».
Perciò, in un’epoca di crescente complessità ambientale e sociale, il ruolo del giornalismo nella comunicazione dei disastri diventa sempre più cruciale, richiedendo non solo competenze tecniche, ma anche una nuova consapevolezza del proprio ruolo sociale e delle responsabilità che comporta. E diventa sempre più cruciale anche il ruolo dell’opinione pubblica, di chi ha la fortuna di guardare i disastri dallo schermo di un televisore o di uno smartphone: essere coscienti di come si svolge l’informazione, e di cosa affronta chi la svolge, è necessario alla corretta lettura di ogni fenomeno, disastroso e non.